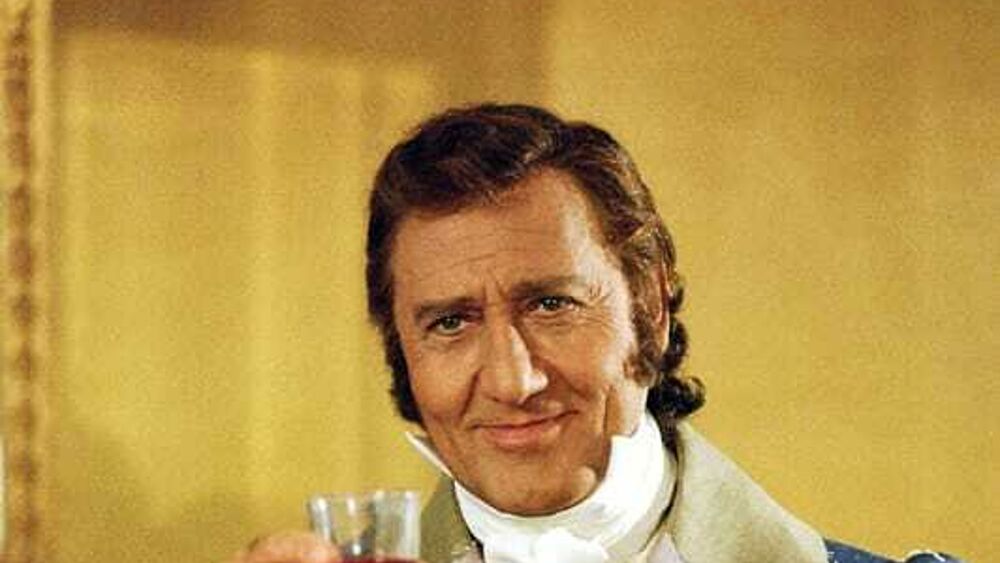(foto: Il Marchese del Grillo, film 1981)
«Era stata proprio una bellissima festa, una festa indimenticabile. In tre anni di guerra non ci eravamo mai tanto divertiti. A sera eravamo stanchi morti, avevamo la bocca tutta indolenzita dal gran ridere, ma eravamo orgogliosi di aver compiuto il nostro dovere. Finita la festa, ci ordinammo in colonna, e così, senz’armi, senza bandiere, ci avviammo verso i nuovi campi di battaglia, per andare a vincere con gli alleati quella stessa guerra che avevamo già persa con i tedeschi. Marciavamo a testa alta, cantando, fieri di aver insegnato ai popoli di Europa che non c’è ormai altro modo di vincer le guerre che buttar le proprie armi e le proprie bandiere, eroicamente, nel fango, ‘ai piedi del primo venuto’» (Curzio Malaparte, La vergine di Napoli)
Il titolo di questo contributo prende spunto dal soprannome che si diede Curzio Malaparte, l’Arcitaliano, appunto. Malaparte fu giornalista, inviato speciale, diplomatico, agente segreto, regista, poeta e saggista italiano, fascista della prima ora e, dopo l’8 settembre 1943, collaboratore degli Alleati, anticomunista e più tardi vicino al partito di Togliatti, e coniò per sé tale soprannome per spiegare la sua personalità complessa e contraddittoria in cui riconosceva molti difetti e pregi degli italiani.
Ci sembra un buon modo per iniziare una lettera in cui, date le imminenti elezioni, vogliamo dar conto di alcuni esempi della nostra storia da cui trarre spunto per guardare al prossimo futuro e immaginare cosa possiamo attenderci dal trasformismo della nostra classe dirigente, senza alcuna velleità di previsione e con un po’ di autoironia perché, come diceva Marx, la Storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa.
VOLTAGABBANA
Il cambiare idea, opinione o fazione è considerato giustamente un atto della sfera morale per simboleggiare il quale, in molte locuzioni, si usa l’immagine di un concreto mutamento nella sfera materiale.La gabbana (o gabbano) è un tipo di cappotto che con vari adattamenti ha attraversato i secoli dal medioevo ai nostri giorni e che, proprio come cappotto e cappa, nasce dal nome arabo qabā’. Ad ogni modo, si dice voltagabbana chi per convenienza e opportunismo cambia facilmente idee e fazioni, così come si cambierebbe un soprabito. L’utilità personale, per il voltagabbana, vince con disinvoltura su ogni lealtà.
Una lunga storia, quella del Belpaese, i cui protagonisti si sono contraddistinti non solo per nobili gesta ma anche, ahinoi, per essersi resi colpevoli di pagine poco edificanti; una storia che è ben rappresentata dai grandi capolavori della letteratura che studiamo a scuola e alle cui pagine, per intere generazioni, abbiamo attinto formando la nostra identità e il nostro modo di intendere il mondo. L’Eneide, la Divina Commedia e i Promessi Sposi, infatti, ci invitano a metterci in relazione con Enea che scappa da Troia, con Dante che risale dagli Inferi al Paradiso in un itinerario di vizi e virtù e, infine, con i travagli patiti con pia rassegnazione da Renzo e Lucia ad opera di despoti ingiusti. Proprio Dante, nel VI canto del Purgatorio, con il famoso verso “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchier in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!” introduce un’amara riflessione sulla condizione politica dell’Italia che, da dominatrice ai tempi dell’Impero romano era decaduta senza guida in balìa dei particolarismi, dei trasformismi e dei ribaltoni. Questi ultimi rappresentano un vero e proprio vizio nazionale di cui riportiamo alcuni esempi, recenti e meno recenti, dai più celebri ai meno noti, perché suggeriamo possano essere la lente attraverso cui interpretare anche la contemporaneità.
1) Partiamo così dall’episodio più famoso, avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, che ha minato la credibilità internazionale dell’Italia fino ad oggi. Infatti, se ancora a distanza di anni la classe politica italiana è considerata inaffidabile, la causa sta nel ribaltone dell’8 settembre 1943.
ARMISTIZIO DI CASSIBILE (3 SETTEMBRE 1943) punti salienti:
Cessazione immediata di ogni attività da parte delle forze armate italiane.
L’Italia farà ogni sforzo per negare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite.
Trasferimento immediato della flotta italiana e degli aerei italiani in quei luoghi che potranno essere designati dal comandante in capo alleato, insieme coi particolari sul loro disarmo che saranno da lui fissati.
Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia delle isole che del Continente, agli Alleati, per essere usati come basi di operazioni e per altri scopi, secondo le decisioni degli Alleati.
Garanzia immediata del libero uso da parte degli Alleati degli aeroporti e basi marittime in territorio italiano, senza tener conto dello sviluppo dell’evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche. Questi porti e aeroporti dovranno essere protetti dalle forze armate italiane finché questo compito non sarà assunto dagli Alleati.
Immediato richiamo in Italia delle forze armate italiane da ogni partecipazione alla guerra in qualsiasi zona in cui si trovino attualmente impegnate.
Il comandante in capo delle forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura che egli ritenga necessaria per la protezione degli interessi delle forze alleate per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a prendere quelle misure amministrative o di altro carattere che potranno essere richieste dal comandante in capo, e in particolare il comandante in capo stabilirà un Governo militare alleato su quelle parti del territorio italiano che egli riterrà necessario nell’interesse militare delle Nazioni Alleate.
Il comandante in capo delle forze alleate avrà pieno diritto di imporre misure di disarmo, di mobilitazione, di smilitarizzazione.
Innanzitutto, occorre partire dall’errore di base compiuto da Mussolini il 10 giugno 1940, quando portò la nazione in guerra perché temeva che i tedeschi l’avrebbero vinta rapidamente da soli e l’Italia non avrebbe potuto partecipare alla spartizione di un apparentemente facile bottino. L’errore, oltre all’impreparazione in termini di cultura bellica delle gerarchie politiche e militari, fu il combattere una guerra tedesca impegnando l’esercito su fronti di poco o nessun interesse strategico nazionale come la Francia e la Grecia, dove i tedeschi furono costretti a rallentare l’invasione della Russia per venire in soccorso dell’Esercito italiano. Errore che non ci perdonarono mai. Infatti, dopo la battaglia di Stalingrado, nella primavera del 1943 divenne chiaro a tutti che la guerra era persa. Gli italiani volevano uscirne al più presto ma i tedeschi volevano utilizzare la penisola come scudo, a maggior ragione dopo aver sacrificato i loro obiettivi per prestare aiuto nei Balcani. L’Italia avrebbe dovuto seguire una strategia analoga, individuare un ridotto e difendersi strenuamente per ottenere quanto meno una sconfitta dignitosa. Il 25 luglio il Gran Consiglio, con una decisione ambigua, criptica per chi non conoscesse i poco onorevoli precedenti, aveva posto termine al Governo fascista che buona parte degli italiani intese erroneamente come la fine della guerra, senza considerare che sarebbe stato necessario un accordo con i tedeschi per uscirne. Questi ultimi non avevano alcuna intenzione di rinunciare alla loro ultima difesa dagli anglo-americani.
La scelta di negoziare in segreto l’armistizio con Stati Uniti e Inghilterra rappresentò un grave errore strategico appunto perché frutto di un’analisi irrealistica della situazione e si configurò come un vero e proprio tradimento con protagonisti i partiti antifascisti, il Re e Badoglio, nome che più tardi decadrà ad aggettivo per ribaltonisti di ogni risma.
L’ipotesi più plausibile per trattare un’uscita dalla guerra più onorevole è che l’Esercito italiano si assestasse sulla Linea Gotica a difesa del Nord Italia come ultima ridotta da difendere ad ogni costo. Uscire in questo modo, oltre che salvare l’onore avrebbe consentito al nostro Paese di scaricare sugli anglo-americani avanzanti l’onere di nutrire i circa 30 milioni di concittadini che erano ridotti alla fame; non dividere gli italiani con l’abbandono da parte del Re di una parte della nazione al suo destino fuggendo al Sud. Sicché, la guerra continuò più dura di prima, scoppiò una guerra civile fra italiani, e alla fine della guerra i vincitori non concessero nulla (Cfr. Birindelli, G., Che cosa avremmo dovuto fare l’8 settembre, in Limes, n. 4, 1998).
2) La Grande Guerra (1915-18). La Seconda guerra mondiale è certamente originata dagli esiti della Prima, tanto che alcuni storici tendono a considerare i due eventi un tutt’uno: la grande guerra civile europea (Cfr. Nolte, E., La guerra civile europea, 1917-1945 – Nazionalsocialismo e bolscevismo, BUR, 2018).

L’Italia, allo scoppio del conflitto, era alleata con la parte “sbagliata” in quanto membro della Triplice Alleanza, con la Germania e l’Impero Austro-Ungarico. La Triplice Alleanza fu firmata nel 1882 in chiave antifrancese ed era stata rinnovata a intervalli regolari. Tuttavia, vi erano dei contrasti tra l’Italia e l’Austria relativamente a Trieste e il Sud Tirolo, considerati dagli italiani “territori perduti”.
All’inizio della Guerra, con l’aggressione alla Serbia da parte austriaca a luglio del 1914, le forze militari italiane erano per lo più concentrate sul confine con la Francia, come prevedeva l’Alleanza. Quando il conflitto si allargò in pochi giorni a buona parte d’Europa, l’allora Primo Ministro, Antonio Salandra, cercò di restare neutrale, in quanto l’Alleanza era a carattere difensivo e la questione non riguardava l’Italia.
A ottobre, lo Stato Maggiore cominciò a spostare reparti dell’Esercito ad Est, verso il confine austriaco e a fine aprile del 1915, con il trattato della Triplice Alleanza ancora formalmente in vigore, ecco il colpo di scena: l’Italia firma in grande segreto il Patto di Londra con la Triplice Intesa (Inghilterra, Francia e Russia) che prevedeva l’entrata in guerra dell’Italia al fianco di questi, che prima erano i nemici. Nel maggio del 1915, l’Italia dichiarò prudentemente guerra alla sola Austria e, solo più tardi nel 1916, alla Germania.

Il cambio di fronte fu motivato dalla promessa di ottenere come bottino di guerra Trieste e i territori “italiani” dell’Impero Austro Ungarico, all’Italia furono invece negate Dalmazia e Albania per il veto della Russia zarista. A fine guerra, malgrado l’enorme prezzo pagato in sangue, gli accordi furono disattesi: gli alleati giustificarono il voltafaccia con il ruolo ambiguo, tra neutralità e interventismo, del Belpaese nei primi anni del conflitto. Oltre il danno, una beffa che generò una spirale di malcontento che, pochi anni dopo, portò all’avvento del Fascismo.
3) La guerra in Libia (2011). Il più recente episodio di ribaltone è stato certamente la guerra a Gheddafi. Nel 2008, veniva firmato il “Trattato di Amicizia e Cooperazione” fra Italia e Libia che sanciva la normalizzazione definitiva dei rapporti tra i due Paesi dopo oltre quarant’anni. Il trattato permise a Gheddafi di compiere alcune controverse visite di Stato in Italia e fu invitato da Berlusconi a partecipare, come presidente di turno dell’Unione Africana, al G8 dell’Aquila, visita che sollevò numerose polemiche e critiche internazionali: l’ambasciatore americano a Roma, David Thorne, espresse infatti dure riserve circa le relazioni tra Italia e Libia. La posizione dell’allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, già guardato con sospetto per l’amicizia personale con Vladimir Putin si fece ancora più difficile. Con lo scoppio delle primavere arabe e la progressiva destabilizzazione della regione, come è noto (non scendiamo nel dettaglio delle tante sfaccettature di questa pagina della storia recente) spinsero un Nicolas Sarkozy bisognoso di successi internazionali a fini elettorali a prendere posizione con l’appoggio del premier inglese Cameron. Quest’ultimo convenne con i francesi che lo status quo fosse insostenibile e che bisognasse intervenire in Nord Africa per evitare che i dittatori riprendessero il controllo o che le rivolte fossero infiltrate dai jihadisti e la transizione dirottata dagli islamisti.
Dopo la firma del Trattato di Bengasi, l’Italia era diventata un hub per gli investimenti libici in Europa e il suo principale partner economico, la fonte del 20% di importazioni e il 40% di esportazioni. Nel 2010, Tripoli era uno dei maggiori azionisti dell’economia italiana: la Libyan Foreign Bank possedeva il 67,5% di Banca UBAE Spa, il 7,5% di UniCredit e, attraverso il Fondo di Investimento Libico (LIA), il 2% di Finmeccanica, il 7,5% dello Juventus Club e il 2% di ENI e FIAT. Gli investimenti italiani ammontavano a circa 11 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali concentrati nella holding di ENI.
In realtà, un appunto inviato per mail all’ex segretario di Stato americano Hillary Clinton smaschera la guerra della Francia all’Italia. Un documento che, rafforzato da diversi file pubblicati da Wikileaks, mostra il chiaro disegno francese per sottrarre i permessi estrattivi in Libia in mano all’italiana Eni (Cfr. Vassallo, M., La guerra francese a Gheddafi per rubare il petrolio italiano, Il Giornale, 07.04.2016). Siamo nel 2011 e i preparativi per la guerra proseguono tra gli Alleati Nato con l’Italia di Berlusconi che fa il possibile per sottrarsi. Tuttavia, con la visita a Roma del senatore John Kerry, emissario di Barack Obama e dopo la telefonata di quest’ultimo a Berlusconi il 25 aprile, il premier italiano garantisce che l’Italia avrebbe rimosso i propri limiti alla partecipazione militare (Cfr. Palma, L., La caduta di Gheddafi e la frantumazione della Libia, in Ispionline, 28.06.2021. E la gabbana viene voltata un’altra volta.
Andando indietro nel tempo e guardando alla storia dell’Italia preunitaria, torna in mente la celebre definizione del vizio nazionale che diede Francesco Guicciardini (1483-1540): “Franza o Spagna, purché se magna”. Lo scrittore toscano nella sua Storia d’Italia racconta esattamente l’inclinazione degli italiani del XV secolo a mettersi a disposizione dell’una o dell’altra potenza straniera pur di salvare un minimo di potere. La riflessione di Guicciardini, vale la pena ricordarlo, ruota attorno al concetto di discrezione e al tema del particulare: l’uomo politico, per lo scrittore toscano, deve avere la capacità di analizzare e comprendere i fatti in tutte le loro possibili sfumature (discrezione) così da poter decidere la propria condotta senza esserne travolto e salvaguardando il proprio tornaconto personale (particulare) (Cfr. Guicciardini, F., Storia d’Italia, ed. Garzanti, 2006). Con la sua Storia, egli riporta del crollo degli Stati italiani di fronte alle potenze straniere durante settant’anni di conflitti: le cosiddette Guerre d’Italia che iniziarono nel 1494 e finirono nel 1559.
In questo periodo, vi furono molti “fulgidi” esempi di voltafaccia per tornaconto personale e, in omaggio al lamento di Dante, ne selezioniamo tre, come le cantiche della Commedia.
1) La Prima guerra (1494-98). Ad esempio, quando nel 1494 il re francese Carlo VIII, rivendicante il trono di Napoli in ragione della discendenza da Maria d’Angiò, scende in Italia grazie all’appoggio Ludovico Sforza di Milano, detto “il Moro”, che ne invocava l’aiuto per supportare la sua scalata al governo del Ducato di Milano contro Gian Galeazzo Sforza. A loro volta, sostennero l’iniziativa del re francese: Venezia perché il re aragonese favoriva i porti pugliesi suoi diretti concorrenti, gli avversari dei Medici a Firenze nella speranza di ottenere un cambiamento di regime e, nello Stato pontificio, i cardinali avversi ad Alessandro VI Borgia per deporre il papa regnante ed eleggere Giuliano della Rovere (il futuro Giulio II). In cinque mesi, dal settembre 1494 al febbraio 1495, Carlo VIII attraversò l’Italia lungo l’antica Via Francigena raggiungendo Napoli nel febbraio 1495. Questa rapida avanzata scompagina il quadro politico: Ludovico il Moro vince le sue pretese dinastiche, Venezia conquista i porti pugliesi e i Medici vengono effettivamente cacciati da Firenze dove viene proclamata la Repubblica. Tuttavia, il trionfo di Carlo VIII spaventa gli italiani che… voltano la gabbana! Lo Stato pontificio, Milano e Venezia si coalizzarono formando una lega antifrancese che ottiene l’appoggio dell’imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano e della Spagna. Carlo VIII si vide costretto a risalire la penisola e riparare in Francia per evitare di restare isolato nell’Italia del sud.

2) Seconda guerra (1499-1504). Alla morte di Carlo VIII, sale al trono di Francia Luigi XII che riprende le mire espansionistiche del suo predecessore e ritorna in Italia con l’intento di conquistare il Ducato di Milano, dando inizio alla. Anche in quest’occasione, ci furono coloro che più di altri si dimostrarono opportunisti: Venezia e lo Stato Pontificio appoggiarono infatti il re francese contro Milano, loro alleato contro Carlo VIII.
3) La Lega di Cambrai. In seguito, nel 1508 l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo, Luigi XII di Francia, Ferdinando II d’Aragona (re di Napoli e di Sicilia), papa Giulio II, Alfonso I d’Este (duca di Ferrara), Carlo II (duca di Savoia), Francesco II Gonzaga (marchese di Mantova) e Ladislao II (re d’Ungheria) si uniscono nella Lega di Cambrai contro lo strapotere di Venezia in Italia, capace addirittura di prevalere in un conflitto con l’Imperatore. Qui è il Papa a prodursi in una nuova piroetta: costituisce, infatti, la Lega Santa con Inghilterra, gli svizzeri, la Spagna e la stessa Venezia contro i francesi, costringendoli ad abbandonare la Lombardia con il Ducato di Milano che passa a Massimiliano Sforza, figlio di Ludovico il Moro. Anche Firenze viene occupata dalle truppe spagnole che ristabiliscono i Medici al potere (Cfr. A.a.V.v, Le Guerre d’Italia, su treccani.it).
In conclusione, è opinione di molti che anche oggi, a causa di una classe politica inetta posta sotto il controllo di poteri transnazionali e di un popolo disinformato, confuso e rancoroso, l’Italia sia alla mercé di potenze straniere. Cosa potrà, quindi, accadere?

Come risposta ci affidiamo alle parole di Sebastien Giustinian, ambasciatore veneziano presso Enrico VIII d’Inghilterra: “La natura del tempo, serenissimo principe, richiede questo, un’osservanza di un vecchio proverbio, che ingiunge di baciare la mano che non possiamo tagliare”.
In chiusura, proponiamo un romanzo dell’Arcitaliano Malaparte, forse il più famoso: La Pelle. Come riportato sul risvolto dell’edizione Adelphi, una terribile peste dilaga a Napoli dal giorno in cui, nell’ottobre del 1943, gli eserciti alleati vi sono entrati come liberatori, una peste che corrompe non il corpo ma l’anima, spingendo le donne a vendersi e gli uomini a calpestare il rispetto di sé. Nella città falcidiata dalla malattia e trasformata in un inferno di abiezione, null’altro rimane se non la lotta per salvare la pelle: non l’anima, come un tempo, o l’onore, la libertà, la giustizia, ma la «schifosa pelle».

Lugano, 11/09/2022