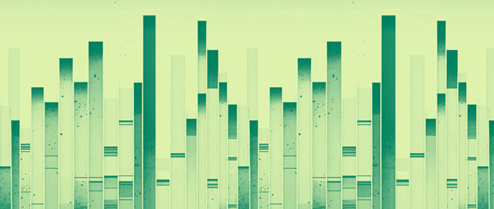It’s times like these
You learn to live again
It’s times like these
You give and give again
It’s times like these
I’m a new day rising
I’m a brand-new sky
That hang the stars upon tonight
Times Like These – Foo Fighters
Come sottolineato anche in altre occasioni, il mondo filantropico sta attraversando una fase di trasformazione significativa, spinta da dinamiche sociali, economiche e politiche in continua evoluzione. Il rapporto 11 Trends in Philanthropy for 2025, pubblicato pochi giorni fa dal Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy (un punto di riferimento internazionale per non profit e donatori), offre una panoramica dettagliata delle principali tendenze che stanno plasmando un settore pieno di sfide e opportunità.
Il Giving Collettivo: Quando la Filantropia Diventa Partecipazione
Storicamente, la filantropia ha visto un ruolo predominante di grandi donatori e fondazioni istituzionali, che hanno indirizzato risorse significative verso cause di interesse pubblico. Tuttavia, negli ultimi anni, sta emergendo un nuovo modello di generosità: il giving circle. Questo schema consente a gruppi di filantropi di unire risorse, competenze e reti per sostenere cause condivise, rendendo il dono un processo partecipativo, con un approccio più strategico e mirato rispetto alla filantropia individuale. Non si tratta solo di mettere insieme risorse economiche, ma anche di condividere conoscenze, esperienze e decisioni.
Secondo uno studio della Collective Giving Research Initiative, i membri dei giving circles tendono a donare il doppio rispetto ai donatori individuali tradizionali e sono più inclini a finanziare cause legate alla giustizia sociale e all’uguaglianza.[1] Lo studio prevede che il giving collettivo raddoppierà nei prossimi cinque anni, segnalando un cambio di paradigma: sempre più persone vogliono non solo donare, ma anche far parte di un processo di cambiamento condiviso. Questa trasformazione sta ridisegnando il ruolo del donatore, che da semplice finanziatore diventa parte attiva di una rete di solidarietà più ampia e consapevole.
Dalla beneficenza all’advocacy: le non profit al tavolo delle decisioni
Le organizzazioni non profit non si limitano più a fornire servizi o a raccogliere fondi: sempre più spesso stanno entrando nell’arena politica per influenzare direttamente le decisioni che riguardano le loro cause. Negli ultimi anni, il coinvolgimento delle organizzazioni non profit nei processi di definizione delle politiche pubbliche è diventato un aspetto sempre più rilevante. Il National Council of Nonprofits sottolinea come molte organizzazioni stiano riconoscendo l’importanza di advocacy e policy engagement per proteggere e rafforzare il proprio impatto sociale.
Cosa sta alimentando questo cambio di passo? Sono quattro i fattori chiave stanno spingendo in questa direzione:
- Affrontare questioni sistemiche: molte sfide che le non profit cercano di risolvere—come il cambiamento climatico, la povertà o le disuguaglianze—non possono essere affrontate solo con finanziamenti e programmi locali. È necessaria un’azione politica su larga scala.
- Amplificare l’impatto della missione: influenzare il processo normativo significa poter migliorare le condizioni strutturali che determinano il successo o il fallimento di un intervento sociale. Un’organizzazione che lotta contro l’insicurezza alimentare, per esempio, può sostenere leggi che garantiscano l’accesso universale ai pasti scolastici.
- Competizione crescente per i fondi: in un panorama sempre più affollato, le organizzazioni non profit si stanno rendendo conto che ottenere un cambiamento legislativo può essere più efficace e duraturo rispetto alla ricerca di finanziamenti a breve termine.
- Un ambiente politico in trasformazione: in un contesto di crescente polarizzazione politica, le organizzazioni non profit stanno assumendo un ruolo sempre più attivo nel rappresentare gli interessi delle comunità che servono.
Secondo ricerche recenti, le organizzazioni che si impegnano attivamente in advocacy e lobbying non solo hanno maggiore impatto, ma ottengono anche finanziamenti più consistenti, grazie alla loro capacità di posizionarsi come attori chiave della società civile.[2]
Sempre più fondazioni a durata limitata
Sempre più fondazioni stanno abbandonando l’idea della filantropia perpetua per adottare un approccio a durata limitata, scegliendo di esaurire le proprie risorse entro un periodo prestabilito piuttosto che distribuire finanziamenti indefinitamente. Questo modello, noto come “spend-down philanthropy”, è in forte crescita.[3]
Le fondazioni che adottano una strategia a durata limitata lo fanno per diverse ragioni, spesso legate all’urgenza di massimizzare l’impatto del loro operato. Destinare ingenti risorse nel presente, anziché distribuirle in piccoli finanziamenti diluiti nel tempo, consente di accelerare il cambiamento sociale e affrontare le sfide in modo più incisivo. Questa strategia non è priva di rischi, legati in gran parte al futuro dell’iniziativa una volta terminato l’intervento.
Inoltre, molte fondazioni scelgono di evitare il rischio di una burocratizzazione eccessiva: operare a tempo indefinito può trasformare le organizzazioni in strutture rigide, più preoccupate della propria continuità che della missione per cui sono nate.
Il 2025 e la “scogliera fiscale”: un rischio per la filantropia?
Nel 2025, gli Stati Uniti si troveranno di fronte a un cambiamento fiscale significativo: la scadenza di diverse disposizioni introdotte dalla riforma fiscale del 2017: alcune agevolazioni attualmente in vigore potrebbero non essere rinnovate o potrebbero essere modificate in modo da rendere meno vantaggioso l’uso della filantropia come strumento di ottimizzazione fiscale. È questo lo scenario definito dagli esperti come una vera e propria “scogliera fiscale”[4].
Se la “scogliera fiscale” ridurrà in modo significativo il flusso di donazioni negli USA, è probabile che gli effetti si riflettano sulle strategie globali delle grandi fondazioni e delle organizzazioni internazionali che dipendono da finanziamenti americani. Per rispondere a questa sfida, gli esperti raccomandano alle organizzazioni filantropiche di prepararsi con strategie di engagement più solide, rafforzando la relazione con i donatori al di là dei benefici fiscali. Creare un legame più profondo tra i filantropi e la missione delle organizzazioni sarà cruciale per mantenere il supporto anche in un contesto fiscale meno favorevole.
L’Invecchiamento della popolazione e le nuove priorità della filantropia
L’invecchiamento demografico sta rapidamente ridisegnando le priorità della filantropia, soprattutto negli Stati Uniti. Secondo il Census Bureau, entro il 2030, tutti i baby boomer avranno superato i 65 anni, portando la popolazione anziana a rappresentare circa il 20% del totale: un cambiamento che trasformerà profondamente la domanda di servizi sociali, sanitari ed economici.[5]
Uno studio del Urban Institute ha evidenziato che il numero di anziani in condizioni di vulnerabilità economica è destinato ad aumentare significativamente nei prossimi decenni. Molti di loro non avranno risparmi sufficienti per affrontare la vecchiaia, soprattutto a causa dell’erosione dei sistemi pensionistici tradizionali e dell’aumento del costo della vita. Di conseguenza, un numero crescente di fondazioni sta orientando i propri finanziamenti verso programmi che garantiscano la sicurezza economica della popolazione senior, con investimenti in housing accessibile, assistenza sanitaria e supporto alla qualità della vita.
L’invecchiamento non è solo un fenomeno americano.[6] L’Italia, in particolare, è uno dei paesi più anziani al mondo, con un tasso di natalità tra i più bassi e un’età media in costante aumento. Qui si rende ancora più urgente coinvolgere nuove generazioni di donatori. Tradizionalmente, infatti, i grandi donatori appartengono alle generazioni più anziane, mentre i giovani tendono a donare in modo diverso, spesso attraverso modelli di “giving collettivo” o donazioni orientate a cause specifiche. Le organizzazioni non profit dovranno adattarsi per attrarre i Millennial e la Generazione Z, che privilegiano trasparenza, impatto misurabile e strumenti digitali per la donazione.
L’evoluzione delle giornate di donazione: il caso del Giving Tuesday
Le giornate di donazione sono ormai una componente essenziale del panorama filantropico globale. Tra queste, il Giving Tuesday, nato nel 2012 come risposta alla frenesia consumistica del Black Friday e del Cyber Monday, è oggi il più grande evento internazionale dedicato alla generosità. Ogni anno, milioni di individui, aziende ed organizzazioni partecipano a questa giornata per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico su diverse cause sociali.
Nel 2024, questa iniziativa ha mobilitato oltre 3,1 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti, segnando un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Il fenomeno non è limitato agli USA: il movimento Giving Tuesday si è diffuso in oltre 80 paesi, assumendo forme specifiche per ciascun contesto culturale e filantropico. Ad esempio, nel Regno Unito si è assistito a una crescita significativa della partecipazione da parte di piccole organizzazioni locali, mentre in Canada e Germania è il settore corporate ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle donazioni.
Tuttavia, gli esperti avvertono che queste giornate rischiano di diventare eventi isolati, piuttosto che veri e propri catalizzatori di impegno a lungo termine. Una ricerca, condotta da Woodrow Rosenbaum, Chief Data Officer di GivingTuesday, ha evidenziato che solo le organizzazioni che mantengono un rapporto attivo con i donatori dopo la giornata di donazione, attraverso una comunicazione personalizzata e aggiornamenti sull’impatto delle donazioni, riescono a mantenere e in alcuni casi ad incrementare la fidelizzazione rispetto a chi si limita a raccogliere fondi una volta all’anno.
Un altro aspetto cruciale è dato dal confronto tra le giornate di donazione e le campagne filantropiche ordinarie. Sebbene il Giving Tuesday generi un volume di donazioni eccezionale, la maggior parte dei fondi si concentra su un numero ristretto di grandi organizzazioni con forte visibilità mediatica. Le piccole organizzazioni, invece, rischiano di rimanere marginalizzate se non adottano strategie mirate per coinvolgere donatori fedeli.
Per questo motivo, programmi di membership possono incentivare il sostegno continuativo, mentre modelli di “match giving”, in cui aziende o grandi donatori raddoppiano le donazioni ricevute, permettono di aumentare l’efficacia della raccolta fondi. Un ruolo fondamentale è svolto anche dalla comunicazione, che aiuta a mantenere alta l’attenzione e la connessione emotiva tra donatori e beneficiari, trasformando un gesto isolato in un impegno costante.
Il futuro del volontariato
Negli ultimi anni, il volontariato ha subito profonde trasformazioni. Secondo il Bureau of Labor Statistics, negli Stati Uniti il tasso di partecipazione al volontariato tradizionale è diminuito del 7% nell’ultimo decennio. Questo calo è stato accentuato dalla pandemia, che ha accelerato il passaggio a forme di volontariato più flessibili e digitalizzate. Inoltre, cresce il cosiddetto “volontariato di competenza”, in cui i professionisti mettono a disposizione le proprie competenze specifiche – dall’IT al marketing – per supportare organizzazioni non profit in modo mirato.
Un report del Points of Light Institute indica che il volontariato aziendale sta diventando una delle principali modalità di coinvolgimento.[7] In Italia, sempre più imprese stanno integrando il volontariato aziendale nelle loro strategie di responsabilità sociale d’impresa (CSR), offrendo ai dipendenti la possibilità di partecipare a iniziative sociali durante l’orario di lavoro. Attualmente, oltre 4.000 imprese, pari al 5% delle aziende con almeno 50 dipendenti, offrono al proprio personale l’opportunità di svolgere volontariato di competenza. Inoltre, altre 21.000 imprese (26%) stanno valutando di introdurre tali programmi in futuro. Al crescere della dimensione aziendale cresce anche la propensione al volontariato: nelle organizzazioni con 250-499 dipendenti, la quota raggiunge il 6,6%, mentre in quelle con più di 500 dipendenti si attesta al 5,5%.
L’ascesa del volontariato aziendale riflette un cambiamento culturale più ampio: sempre più lavoratori, soprattutto le nuove generazioni, scelgono di collaborare con aziende che dimostrano un autentico impegno sociale. Per le organizzazioni non profit, questa tendenza rappresenta un’opportunità significativa per attrarre competenze altamente qualificate e rafforzare il proprio impatto sul territorio.
Filantropia per la giustizia sociale negli USA
La filantropia orientata alla giustizia sociale si concentra sul sostegno a iniziative che mirano a garantire pari opportunità e accesso alle risorse per tutti i cittadini. Tuttavia, negli ultimi anni, questo settore ha incontrato sfide significative, in particolare a causa dell’aumento della polarizzazione politica e del cambiamento nelle priorità di finanziamento da parte di enti filantropici e donatori privati.
Secondo il Philanthropy for Social Justice and Peace Report del 2024, i finanziamenti destinati a programmi volti a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali hanno subito un calo significativo determinato dalla concentrazione degli investimenti in settori come il cambiamento climatico. Di fronte a questa evoluzione, le organizzazioni impegnate in questo ambito stanno esplorando strategie alternative per garantire la sostenibilità delle loro iniziative. Tra queste vi è una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento, il coinvolgimento di nuovi stakeholder del settore privato e l’adozione di modelli di impatto misurabile che possano attrarre investitori filantropici interessati a risultati concreti e verificabili.
Conclusione: un settore al bivio
Il panorama della filantropia sta cambiando rapidamente, spinto da sfide globali, mutamenti demografici e nuove aspettative sociali. L’idea stessa di donazione sta evolvendo, passando da modelli tradizionali a forme più strategiche, orientate all’impatto e alla sostenibilità a lungo termine. Tuttavia, questa trasformazione porta con sé interrogativi cruciali.
Le fondazioni che scelgono di esaurire il proprio capitale invece di conservarlo per il futuro stanno davvero massimizzando il loro impatto? La crescente digitalizzazione del volontariato rappresenta un’opportunità o rischia di ridurre l’impegno diretto nelle comunità? E il calo delle donazioni per la giustizia sociale è un segnale di una società meno attenta alle disuguaglianze o solo il risultato di una crescente polarizzazione politica?
Questi non sono semplici aggiustamenti di rotta, ma veri e propri banchi di prova per il futuro dell’intero settore filantropico. In un mondo sempre più instabile e frammentato, la capacità delle organizzazioni filantropiche di rispondere in modo efficace e tempestivo determinerà non solo la loro rilevanza, ma anche il loro stesso ruolo nel plasmare il cambiamento sociale.
Approfondimento a cura di Beatrice Marzi
Lugano, 9 febbraio 2025
[1] Eikenberry, A. M., Bearman, J., Brown, M., & Jensen, C. (2017). The State of Giving Circles Today: Overview of New Research Findings. Collective Giving Research Group. Retrieved from [https://philanthropy.indianapolis.iu.edu/doc/institutes/giving-circles2017-executive-summary.pdf]
[2] Independent Sector. (2023). Unlocking the Impact of Funding on Nonprofit Advocacy. Retrieved from https://independentsector.org/blog/unlocking-the-impact-of-funding-on-nonprofit-advocacy.
[3] “What Does It Take to Spend Down Successfully?” Philanthropy New York, https://philanthropynewyork.org/resources/what-does-it-take-spend-down-successfully.
[4] l Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) del 2017 ha elevato il limite di deducibilità per le donazioni in denaro a organizzazioni caritatevoli dal 50% al 60% del reddito lordo rettificato (AGI). Tuttavia, questa disposizione è destinata a scadere il 31 dicembre 2025, momento in cui il limite tornerà al 50% dell’AGI. – U.S. Congressional Research Service, Temporary Individual Income Tax Provisions (“Tax Extenders”), Report R47846, 2023. Disponibile su: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47846
[5] U.S. Census Bureau. (2018). Older People Projected to Outnumber Children for First Time in U.S. History. Retrieved from https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/cb18-41-population-projections.html.
[6] Secondo le proiezioni di Eurostat, la percentuale di persone di 65 anni e oltre nell’Unione Europea è destinata ad aumentare dal 21,1% nel 2022 al 32,5% nel 2100. In Italia, l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) prevede che, entro il 2050, le persone di 65 anni e più potrebbero rappresentare il 34,5% della popolazione totale. Si veda : Eurostat, “Population projections in the EU,” disponibile su: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_projections_in_the_EU; Istituto Nazionale di Statistica (Istat), “Previsioni della popolazione residente e delle famiglie,” disponibile su: https://www.istat.it/it/files/2023/09/Previsioni-popolazione-e-famiglie.pdf
[7] Points of Light. (2023). Annual Report FY2022. Si veda: https://issuu.com/pointsoflight/docs/2023_marcom_report_annual_fy2022_v6_singles.